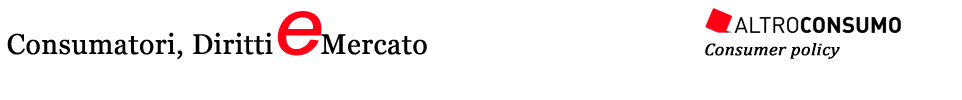Date le condizioni in cui versa il nostro Paese è comprensibile che si cerchi di difendere il made in Italy, uno dei pochi punti di forza che ancora abbiamo. Ma, come noto, la miglior difesa è l’attacco, agire concretamente per rafforzare le imprese dei settori che si identificano con il made in Italy facendo riferimento ad uno scenario di mercato che abbia un minimo di realismo. E si ha spesso l’impressione che per non prendere atto della realtà la difesa prevalga sull’attacco.
Vediamo anzitutto la difesa e i suoi punti deboli, che si possono mettere in luce con qualche semplice esempio. La pasta è un prodotto identificato con l’Italia, uno dei primi ai quali viene di pensare con riferimento all’alimentare. È anche un comparto in cui esistono alcuni grandi produttori e molti di loro hanno aperto impianti in altri Paesi. E per fortuna che lo hanno fatto perché altrimenti lo avrebbero fatto imprese di quei Paesi. Ma è ancora made in Italy? Le materie prime sono reperite sul mercato locale o internazionale, gli impianti sono delocalizzati, le tecniche di produzione sono ormai liberamente disponibili a chiunque e di italiano resta solo la proprietà. Se l’impresa italiana fosse acquistata da un gruppo estero, possibilità tutt’altro che implausibile, i difensori del made in Italy senza se e senza ma si troverebbero di fronte a un subdolo caso di un prodotto Italian sounding che opererebbe come tale anche in Italia.
Dalla pasta al caffè, un prodotto che di italiano non ha certo la materia prima e neppure la lavorazione (tostatura), ma solo le modalità di preparazione per il consumo: espresso e cappuccino. Cosa c’è dunque di italiano? Se mai, come prodotto, le macchine per la preparazione, visto che per il resto tutto è piuttosto semplice e alla portata di chiunque. Ed è significativo che l’innovazione più rilevate di questi anni nel settore del caffè, le cialde, arrivi dalla svizzera Nestlé, che ha inventato una modalità di preparazione che consente di ottenere un ottimo prodotto finito all’italiana, l’espresso. Pasta e caffè (espresso), così come molti altri prodotti alimentari, sono in realtà l’espressione non tanto di originalità produttive, ma di una cultura alimentare che ha una forte identità e che oggi abbiamo la fortuna di vedere diffondersi nel nuovo contesto globale. Possiamo cercare di trarne vantaggio, ma non possiamo credibilmente impedire che altri, magari italiani trapiantati in altri Paesi, producano questi prodotti nei mercati dove vengono consumati e li connotino per quello che sono, appunto prodotti della cultura alimentare italiana.
In altri casi, quando i prodotti hanno un’origine territoriale più definita, si è riusciti a proteggerli con un marchio identificativo, come il parmigiano o il gorgonzola, e la linea di difesa appare più cogente e si può sperare che regga meglio, ma senza farsi troppe illusioni. Si può e si deve cercare di difendere il nome del prodotto, ma sarebbe irrealistico pensare che a fronte di un successo non si apriranno falle. Del resto è proprio quello che abbiano fatto noi (correttamente, bisogna sottolinearlo, senza usare French sounding) quando, nell’impossibilità di usare il nome champagne, che i francesi sono riusciti a difendere con successo, ci siamo inventati quello di spumante e oggi siamo il loro maggiore concorrente. Ma i problemi con i prodotti tipici non riguardano solo l’export: cosa dovrebbero dire i romani che si trovano a comprare il pecorino romano fatto per il 90% in Sardegna?
Se dall’alimentare passiamo all’abbigliamento e all’arredamento, le altre due “a” forti nel mercati al consumo, l’identificazione con l’italianità diventa a ancora più generica, poiché si limita a uno stile che in un mondo globalizzato, dove tutto si mischia, sarà sempre più arduo riconoscere e che, in realtà, nasce da punti di forza che non stanno nella tradizione culturale, ma nell’esistenza di filiere molto forti, capaci di produrre cose che altrove è molto difficile fare e che, non a caso, vengono a fare in Italia anche produttori di grandi marchi esteri: le scarpe di Louis Vuitton sono a tutti gli effetti made in Italy.
Tutto quanto detto non per sminuire l’importanza del made in Italy, anzi, ma per sottolineare che una politica tutta in difesa non potrà dare che risultati limitati, che prima o poi, e tanto più prima nei casi di successo, l’Italian sounding finirà per arrivare sul mercato e non sarà facile fermarlo. Allora meglio l’attacco della difesa. Ma per attaccare va preso atto di una realtà, quella dei mercati globali di oggi, dove ci sono grandissime opportunità per i prodotti della cultura italiana e delle filiere italiane a patto che ci si muova attrezzandosi in modo adeguato.
Nell’alimentare la condizione per sfruttare un contesto così favorevole è anzitutto legata alla scala, alle dimensioni d’impresa che sono troppo spesso insufficienti. Per l’industria, la possibilità di entrare negli assortimenti della grande distribuzione che opera all’estero, quella che serve la gran parte dei consumatori e che è certamente disponibile ai prodotti italiani, richiede prodotti adeguati per quantità e qualità, e capacità di interfaccia con strutture aziendali complesse e molto strutturate. Lo spazio per produzioni artigianali, con forti connotazioni territoriali non è mai stato così ampio, ma a patto che l’artigianalità sia ridefinita in un contesto di globalizzazione, dove nicchie di prodotto anche minute impongono volumi e competenze elevati. Considerazioni analoghe si applicano a chi, produttori o operatori del fuori casa, voglia presentarsi direttamente in Italia o all’estero con punti di consumo: come dimostra il caso di Eataly. Ed è bene non farsi troppe illusioni sulla possibilità di aggirare gli ostacoli facendo leva sulla distribuzione via internet. Per i più piccoli può sì essere un modo per avere un accesso diretto al consumatore senza dover cedere una parte troppo consistente dei margini ad intermediari, ma ricordando che quello virtuale è un mercato dove non è facile conquistare visibilità e che nell’alimentare rimane per il consumatore un canale integrativo piuttosto che sostitutivo di quello fisico.
Nell’arredamento il problema di fondo è lo stesso, trovare il modo di fare convivere un imprinting artigianale, che è una componete costitutiva del made in Italy e del suo successo e che va quindi preservata, con la necessità di affrontare un mercato globalizzato che per essere raggiunto richiede una scala operativa adeguata. Con una qualificazione in più legata alle modalità con cui in questo settore si arriva al consumatore, ovvero una rete distributiva propria di flagship store nei principali mercati o almeno tale da garantire che i prodotti vengano presentati in modo adeguato attraverso corner o shop in shop. Chi non ha le risorse per farlo, anche gradualmente, può solo affidarsi ad intermediari che trattengono gran parte dei margini disponibili, riducono la redditività e rendono difficile uscire da una condizione di sottoutilizzazione delle potenzialità dell’impresa. Se non si trovano le risorse per questo salto di scala, non rimane che rassegnarsi alla cessione a operatori che le hanno o vedere il proprio mercato naturale occupato da produzioni Italian sounding, un fenomeno che è un’indiretta misura delle opportunità che le imprese italiane non riescono a cogliere a causa delle loro insufficienti dimensioni.
Ma è nel caso dell’abbigliamento che le condizioni per sfruttare il made in Italy emergono in modo forse più netto e chiaro. Il settore è infatti assai più avanti sia dell’alimentare che dell’arredamento nel processo di internazionalizzazione e dunque il made in Italy si è trovato ad affrontare prima le sfide che esso impone. La condizione per poter fare valere le grandi griffe è ormai legata alla possibilità di disporre di reti globali di negozi monomarca, reti che risiedono grandi investimenti per essere sui fronti strada delle principali vie dello shopping del mondo. E’ la principale motivazione che ha portato alcuni imprenditori a cedere le loro imprese ai maggiori gruppi del lusso o a soggetti che disponevano delle risorse finanziarie necessarie a valorizzare i loro marchi. (Ma anche, va ricordato, le italianissime Prada e Luxottica ad acquisire, rispettivamente, l’inglesissima Church’s e le americanissime Oakley e Ray-Ban, a riprova del rimescolamento di carte indotto dalla la globalizzazione dei mercati).
In definitiva, bisogna che il made in Italy guardi in faccia la realtà e prenda atto che il problema da superare è anzitutto quello delle dimensioni: sotto una certa scala, diversa da comparto a comparto, il mercato globale non si conquista e, essendo noto che gli spazi vuoti si riempiono, finirà per essere occupato che imprese di altri Paesi che sono in condizioni di farlo.