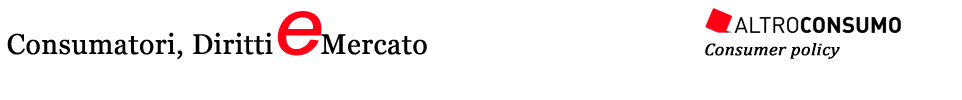Negli anni della crisi l‘esigenza di rivitalizzare le economie nazionali attraverso servizi più efficienti per i consumatori sembra passare attraverso il definitivo superamento del modello dello Stato Gestore, rilanciando il tema della privatizzazioni in tutta Europa.
In Italia, questo processo è iniziato con la denazionalizzazione dell’IRI nel 1985 e con le prime dismissioni di Sirti e STET, anche se la vera accelerazione del processo si ebbe negli anni ’90, ancora una volta sollecitati dal processo di unificazione europea che imponeva l’eliminazione di qualsiasi trattamento preferenziale per le imprese a partecipazione pubblica. Proprio in quegli anni si privatizzarono colossi del calibro di Mediobanca (1988), Ina (1994), parte di ST (1994), l’Istituto Bancario Sanpaolo (1997), Saipem (1998). Per alcuni autorevoli osservatori, come l’Istituto Bruno Leoni, che da anni promuove la liberalizzazione del mercato italiano, il programma delle privatizzazioni italiane può dirsi tutt’altro che concluso, e molte sono ancora le società di Stato che invece dovrebbero essere cedute (da Eni a Finmeccanica, da Poste ad Anas). Recenti dichiarazioni del Ministro del Tesoro Saccomanni fanno pensare che alcune delle aziende sopra elencate saranno vendute. La prospettiva di vendita a privati di imprese tradizionalmente gestite dallo Stato nel contesto emergenziale della crisi sembra, pertanto, ritornare in auge, motivata forse dalla volontà di “fare cassa” e acquisire risorse economiche necessarie al risanamento economico piuttosto che da necessità di ripristino dell’efficienza in settori in cui la gestione pubblica ha mostrato di essere inadeguata. Tuttavia, a oggi l’esito dei processi di privatizzazione, di ieri e di oggi, nel nostro paese appare insoddisfacente. È ovvio che la prospettiva di un loro rilancio sia anche densa di rischi per i consumatori ed un’analisi attenta di quanto avvenuto fino ad oggi non può che mettere sull’avviso tanto gli utenti che le associazioni che li rappresentano.
Secondo i dati forniti dal Privatization Barometer della Fondazione ENI si è riscontrato un aumento dei ricavi dei processi di privatizzazione avviati in Europa, soprattutto negli anni 2009 e 2010, in cui si è raggiunto il valore 225 miliardi di dollari, anche se il precedente record risale al solo 2005, dove si era raggiunta quota 180 miliardi di dollari. Il dato testimonia come i processi di privatizzazione nel continente, iniziati tra gli anni ‘80 e ’90 per affrontare la difficile congiuntura economica, siano negli anni della crisi economica ripresi d’intensità, soprattutto nel settore dei servizi elettrici, idrici e di quelli postali. Dal 1985 sino a oggi, lo stato italiano ha ricavato più di 160 miliardi di dollari dalle privatizzazioni e vanta il primato europeo (escludendo il Regno Unito) in termini di proventi ottenuti.
Se da una parte i benefici in termini d’incasso sembrano dunque essere positivi e innegabili, anche per il nostro paese, valutazioni più prudenti e non sempre facili attengono al piano del miglioramento dell’efficienza e dei benefici per i consumatori.
Se si considerano alcuni casi emblematici a livello europeo, si è dimostrato come il processo di privatizzazione non ha comportato sempre dei passi in avanti su questo fronte: un esempio è stata la nazionalizzazione della National Express britannica, che collega Londra con la Scozia, in quanto i costi in sussidi pubblici alle imprese private per quella tratta si erano rivelati più alti di quelli anteriori alla privatizzazione, con evidenti deficit anche sul piano della puntualità del servizio e degli investimenti sull’efficienza e la capacità delle vetture che la privatizzazione avrebbe dovuto incoraggiare; anche l’esperienza britannica di privatizzazione della rete infrastrutturale ferroviaria si è rivelata dannosa, in quanto non solo non sono aumentati gli investimenti di ammodernamento ma sono aumentati anche gli incidenti; un ulteriore esempio degli ambigui risultati della privatizzazione è il caso francese dove EU De PARIS, nuova regie in mano pubblica dal 2010 gestisce l’intera filiera dell’acqua parigina dopo un lungo periodo di gestione del servizio in mano a tre società private, iniziato nel 1985, che aveva portato a continui aumenti tariffari per i consumatori della capitale francese a fronte invece di investimenti molto contenuti sulla rete idrica.
In Italia si possono citare altrettanti esempi controversi: uno fra tutti il caso Alitalia, la cui privatizzazione viene ultimata nel 2008 con il passaggio a CAI che, sull’onda di un campanilismo tutto italiano, acquisisce l’ex compagnia di bandiera a un prezzo inferiore rispetto a quanto offerto dai maggiori concorrenti francesi di Air France, accollando però allo Stato buona parte dei debiti della società, confluiti nella bad company Alitalia Service, e senza aver aumentato in maniera significativa la qualità del suo servizio agli utenti e non riuscendo comunque a risollevare le sorti economiche del vettore. I recenti fatti riguardanti il caso Telecom e la recente acquisizione da parte di Telefonica a causa della esposizione debitoria dell’azienda mettono in discussione i benefici del processo di privatizzazione del principale operatore di telefonia fissa, mentre il nodo delle questione proprietaria della rete continua a essere rimandato paventando nuovi rischi per la privacy degli utenti. Anche la separazione tra SNAM ed ENI, promossa dal governo Monti, sembra non aver prodotto i risultati sperati in termini di prezzo per gli utenti e, allo stato attuale, appare più un’operazione di facciata in quanto il subentrare la Cassa Depositi e Prestiti nella proprietà dell’azienda, come dice Stagnaro, appare ad un atto di sostanziale “ristatalizzazione”. Nel caso poi dei servizi idrici, l’elevata partecipazione e i risultati referendari del 2011, mostrano chiaramente esiti contraddittori. L’elevato contenuto simbolico del bene “acqua” ha determinato una grande mobilitazione sviluppatasi intorno al tema della sua “privatizzazione” che alla fine sembra aver generato alcuni esiti paradossali: non solo non ha impedito la gestione dei servizi idrici ai privati, che gestiscono comunque il 7% dei servizi idrici nazionali, perlopiù nel Sud-Italia, ma ha prodotto una maggiore incertezza normativa a causa della parziale abrogazione dell’articolo 154, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, che stralciando il riferimento alla «adeguatezza della remunerazione del capitale investito», ha reso meno chiara la possibilità di recuperare il costo degli investimenti sulle tariffe. Ciò ha prodotto una situazione di duplice stallo: si sono scoraggiati gli investimenti privati necessari ad ammodernare la rete idrica nazionale in gravi condizioni d’inefficienza, e si è paralizzata l’attività legislativa necessaria a sanare simili dubbi in quanto l’elevata partecipazione referendaria ha reso assai “scomodo” politicamente un qualsiasi intervento normativo sull’acqua. Va altresì rilevato che le public utilities come acqua, servizi d’igiene urbana e trasporto locale, sono assai meno redditizie rispetto al settore dell’energia e del gas, mentre hanno costi del personale più elevati che, secondo Liberati, incidono fino al 50% del loro valore aggiunto. Questi dati vanno affiancati alla costatazione del fallimento del cosiddetto “capitalismo municipale”, cioè quelle aziende che gestiscono i servizi a livello locale, formalmente private ma che sono controllate in massima parte da un azionista pubblico. In proposito, i numerosi scandali emersi nel settore dei rifiuti e del traporto urbano confermerebbero come la sfera politica continui a generare forti pressioni sulla gestione di questi servizi, soprattutto a causa del fatto che la partecipazione pubblica è di controllo, rendendo solo formale la separazione tra la loro programmazione, la loro gestione e il controllo dei risultati; le imprese aperte al capitale privato (le cosiddette società miste) presentano una redditività e un’efficienza gestionale significativamente superiore a quelle in cui la partecipazione pubblica è totalitaria ma appaiono anche più indebitate, in quanto la volontà politica di evitare aumenti tariffari impone all’impresa di ricorrere in maniera sistematica al debito bancario.
Concludendo, i limiti delle privatizzazioni italiane nella loro capacità di produrre benefici per i consumatori possono essere ricondotti ad alcuni fattori principali: un modello di privatizzazione “autogestista”, in cui erano gli stessi manager e dirigenti pubblici a decidere “cosa” e “come” vendere; la presenza di percorsi regressivi in cui alcune imprese privatizzate erano subito dopo rinazionalizzate (il caso Enimont che poi è rivenduta a ENI); oppure paradossali casi di vendita da un attore pubblico a un altro; l’avvio della vendita ai privati delle imprese pubbliche, senza avere preventivamente o contestualmente proceduto a un’effettiva liberalizzazione del settore economico in cui queste operavano, senza una reale preoccupazione rispetto a logiche di efficienza o di tutela d’interessi diffusi, ma piuttosto motivato dalle sole esigenze di cassa, con tentativi regolatori solo ex post. È stato altresì rilevato come un ulteriore errore sia stato procedere solo in rari casi a cessioni totali delle aziende controllate, facendo sì che lo Stato italiano perpetrasse il suo doppio ruolo di azionista e di arbitro nella regolazione.
Dunque quali prospettive per non ripetere gli errori del passato? Certamente la risposta più semplice al quesito è quella di aumentare la trasparenza del processo di privatizzazione, favorendo non solo il controllo delle autorità di regolazione eventualmente competenti ma anche delle associazioni dei consumatori o di altri stakeholder coinvolti. Un’ulteriore garanzia potrebbe essere proprio quella di prevedere all’interno dei consigli di amministrazione delle società da privatizzare la nomina di rappresentanti di associazioni o comitati di cittadini in qualche modo interessati da un simile processo. Rafforzare la condizione “attiva” dei consumatori significa attuare una strategia di contrasto efficace all’azione di pressione corporativa esercitata da alcuni gruppi economici del paese che ha condizionato pesantemente la storia delle liberalizzazioni italiane e i benefici che da questi ne potrebbero derivare anche per i consumatori.