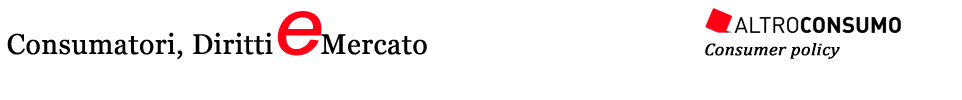Tassare o non tassare le bibite analcoliche zuccherine e i superalcolici? La domanda è parte della più generale questione se ricorrere o meno alla leva fiscale per correggere abitudini alimentari dannose per il singolo e, attraverso le esternalità e le interconnessioni economiche tra singolo e società, dannose per tutti i cittadini.
Se il discorso resta su un piano teorico-filosofico, la contrapposizione tra sovranità del consumatore nelle sue scelte quotidiane e principi di “raccordo” con equilibri collettivi è condannata a rimanere insoluta. È quanto ha dimostrato il rapido e incompleto dibattito che si è svolto in Italia nel mese di Agosto 2012, dopo la proposta, poi abbandonata, di adottare una “tassa pro salute”. È necessario contestualizzare il più possibile per tenere conto della complessità dei mercati (potere del marketing, sollecitazioni multimediali, mode globalizzate, etc.), delle proporzioni macroeconomiche che le singole azioni di consumo possono raggiungere quando sono diffuse e frequenti (in primis sui conti della sanità e del welfare), e soprattutto delle interdipendenze sempre più forti che legano tra loro i comportamenti dei cittadini nelle società moderne, anche al di là dei confini nazionali.
Se la “tassa pro salute” – la “soda tax” all’italiana” – è stata stralciata del pacchetto proposto dal Ministero della Salute, il dibattito contrario ha evidentemente pesato di più di quello a favore.
Ma le motivazioni che sono arrivate a favore appaiono tutt’altro che infondate e definitivamente archiviabili. In realtà, sono le motivazioni contrarie ad apparire deboli, sia ad una analisi di tipo economico-giuridico sia, ancor prima, ad un vaglio logico.
Bibite zuccherine e superalcolici non sono alimenti di sostentamento dei più poveri; e anche se si fosse trattato più in generale dello “junk food”, sarebbe stato ugualmente sbagliato (anche ipocrita e populista) usare l’argomento della redistribuzione per difendere questa categoria da tasse ad hoc che tentassero di disincentivarne il consumo. Non è lasciando a buon mercato questi alimenti, di così bassa qualità da essere dannosi per la salute, che si può presumere di mettere in atto una politica redistributiva a favore delle fasce più deboli. Anzi, a ben vedere, è esattamente il contrario: persone e famiglie con pochi mezzi hanno anche meno possibilità di curarsi una volta acquisite patologie croniche (come obesità, diabete, ulcere, etc.); mentre l’effetto negativo del “junk food” sulla salute dell’intera cittadinanza finisce per pesare sui bilanci della sanità e del welfare system, sottraendo risorse che potrebbero essere finalizzate a programmi di inclusione sociale e al potenziamento delle prestazioni per le fasce deboli.
Il rilievo di quest’ultimo punto diviene tanto più importante se si dà uno sguardo alle proiezioni a medio-lungo termine della spesa sanitaria, per prestazioni sia acute sia di assistenza continuata ai non autosufficienti. In Italia, come dappertutto nei Paesi a economia e welfare sviluppati, l’incidenza sul Pil è destinata a crescere continuamente, e sarà sempre più importante, indispensabile, bilanciare l’obiettivo dell’adeguatezza delle prestazioni con quello della sostenibilità finanziaria. Una delle leve per evitare che i due obiettivi entrino in contrasto diretto tra di loro, con un trade-off pesante sul piano politico e sociale, è la prevenzione. La leva fiscale per stimolare le abitudini più virtuose dal punto di vista della salute va valutata in questa prospettiva; e, se così si fa, allora la contrapposizione di principio <sfera privata vs. intromissioni pubbliche> viene a cadere e i veri snodi di policy rimangono l’equilibrio e la coerenza con cui la fiscalità viene utilizzata a questo scopo. Non c’è, in altri termini, un pregiudizio di principio.
Equilibrio e coerenza. I punti deboli dell’intervento sono stati proprio questi, che non sono mancati infatti nel dibattito. Il dibattito contrario ha sollevato, dunque, anche questioni importanti che non vanno dimenticate in previsione di un futuro ripensamento sull’uso della fiscalità per stimolare abitudini alimentari virtuose.
La tassa è stata proposta in tempi troppo rapidi, all’improvviso, in un frangente in cui le difficoltà di finanza pubblica obbligano a ricercare modalità di far cassa limitando il più possibile i controeffetti sull’economia. Questo è sembrato agli osservatori e ai cittadini. E, a dire il vero, da parte del Ministero proponente non si sono visti gli sforzi necessari per inquadrare l’introduzione della tassa in un “nuovo corso” della fiscalità, per farla apparire come il primo passo di una riorganizzazione dell’imposizione sul consumo. L’indicazione di un termine di applicazione – i tre anni – certo non ha aiutato, e anzi è parsa la conferma di un intervento di urgenza al solo fine di raccogliere cassa. Di qui sono scaturiti, e anche a buon diritto, i timori dell’ennesimo aggravio su una pressione fiscale già alta, e di un trattamento discriminatorio tra beni e tra mercati. Bastava una enunciazione chiara, eventualmente anche formalizzata in un comma o in un articolo, che si trattava di un avvio di una qualità nuova dell’imposizione sul consumo, che nei successivi anni si sarebbe andata completando e affinando.
Se questa enunciazione non è arrivata probabilmente dipende dal fatto che le idee non erano chiare in partenza, e che quindi almeno una parte delle critiche sopraggiunte avevano fondamento.
L’importante, adesso, è sapere tenere distinte queste critiche (short terminism, obiettivi di cassa, mancanza di una visione di sistema, etc.), da quelle di principio (una tassa sbagliata, vessatoria e invadente, etc.). Affinché questo tentativo un po’ maldestro e abortito non impedisca, in futuro, di avvalersi di uno strumento dalle qualità e dagli effetti che potranno rivelarsi importanti e utili. La prossima volta, che si spera non troppo lontana, sarà forse il caso di discutere di rimodulazione delle aliquote Iva, in maniera tale da non introdurre balzelli in più, da rendere più chiaro che l’obiettivo non è far cassa, e da poter affiancare – sempre senza esagerazioni classificatorie – ai disincentivi alle abitudini alimentari dannose anche incentivi alle abitudini (alimentari e non) virtuose e con esternalità positive.
Bisogna cambiare prospettiva e spiegarla ai cittadini. Se così si procede, la tassa sugli alimenti dannosi smette di far paura e di apparire un residuato di qualche passato illiberale, e può trovare le sue fondamenta economiche e giuridiche. Bisogna, però, saperla disegnare e utilizzare bene, magari impostandola nella forma di una rimodulazione delle aliquote Iva e, visto che la materia Iva è da tempo oggetto di tentativi di convergenza europea, dandole da subito un respiro europeo.